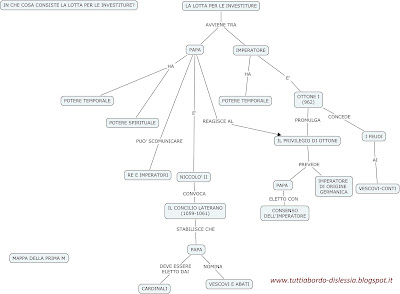“In Italia non esistono veri giornalisti fotografi, perché non esiste una stampa qualificata per ospitarli. I settimanali italiani, dai più popolari ai più sofisticati, dai più impegnati a quelli che professano vaghezza, tutti, senza esclusione, hanno in comune o separatamente due vizi capitali. Il primo è l'insicurezza economica; il secondo la mistificazione. I pochissimi che ancora resistono sono costretti a lavorare esclusivamente per i settimanali stranieri”.
Se non vi dicessi la data, queste parole penso potrebbero apparirvi molto attuali.
Ma furono scritte oltre mezzo secolo fa, da un fotoreporter deluso, amareggiato ma non pentito, sul punto di abbandonare una non lunga ma intensa carriera che lo aveva portato sulle pagine dei grandi magazine mondiali.
Il suo nome dirà molto poco ai più: Calogero Cascio. E questa dimenticanza fa già parte del problema che lui aveva intravisto già allora.
Diego e Natalia, i figli di Calogero, devoti e amorevoli custodi della memoria paterna, hanno voluto che quelle parole fossero scritte in grande su una parete del Museo di Roma in Trastevere dove, per la prima volta dalla sua morte, il lavoro di Cascio è stato finalmente ritrovato, riordinato ed esposto (con la cura di Monica Maffioli) in una bella, precisa, suggestiva, non retorica mostra.
Me le mostrano, quelle parole, con un affetto venato da tenero rimpianto. Del papà fotografo hanno ricordi d’infanzia: camere oscure, carte, apparecchi strani.
Calogero “Lillo” Cascio abbandonò tutto nel 1971, per dedicarsi ad altro: comunicazione, editoria. “Sono profondamente stanco di appartenere a una macchina nella quale non credo e, tanto per salvare lo spirito della contraddizione, mi ci trovo dentro sempre di più”, aveva scritto a un amico.
E ancora: “C'è una stanchezza di base contro la quale ormai è eroico lottare usando lo strumento mio e cioè la macchina fotografica”.
C’è da meditare su queste parole, su quella scelta. Cascio aveva rinunciato a una carriera di medico per dedicarsi in diverso modo all’uomo, con la fotografia; trasferito dalla sua Sicilia a Roma, aveva animato un gruppo tra i più vivaci (con i fratelli Sansone e Caio Mario Garrubba – di cui è aperta in questi giorni una mostra a Roma su cui spero di tornare).
Nel 1964 aveva varcato la soglia allora dirimente del Mondo di Pannunzio con ben cinque fotografie pubblicate in tre numeri consecutivi.
Solo pochi anni prima dell’abbandono aveva raggiunto la soglia imperiale di un fotografo di quegli anni: le pagine di Life.
Tra tutti i servizi che aveva proposto, reportage sui dolori del pianeta realizzati in India, Vietnam, Brasile, Colombia, il magazine americano aveva scelto una storia siciliana, la guarigione dalla cecità dei cinque fratelli Rotolo, per merito di un intervento allora pioneristico di un chirurgo oculista.
Il servizio era rimbalzato poi su Look e Paris Match, e il gran pontefice del MoMa John Szarkowski lo aveva incluso nella sua mostra The Photo Essay. Cosa chiedere di più?
Ma Lillo Cascio, a quanto pare, soffriva non tanto per una sottovalutazione personale, ma per una condizione generale del suo mestiere che riteneva ormai compromessa.

Calogero Cascio:Stato del Pernambuco, Brasile, 1963, Le squadre armate dei latifondisti. © Archivio Cascio
Lo era veramente? Già allora? Curiosamente, nello stesso anno in cui Cascio abbandonava il mestiere, il 1971, combatté la sua ultima battaglia sindacale per il diritto dei fotoreporter a iscriversi all’Ordine del Giornalisti. Dunque?
Il grido di dolore che attraversa oggi il mondo del fotogiornalismo tende a deformare la visione del passato. La crisi degli sbocchi editoriali ci fa immaginare che sia esistita se non proprio un’età dell’oro (che pure è esistita, nei primi decenni del dopoguerra) almeno una condizione di relativa agibilità per il fotoreportage durata fino all’avvento del digitale e del Web.
Non è così. Qualche anno fa la benemerita riscoperta di una mostra epocale per il fotogiornalismo italiano, L’informazione negata, che è del 1981, fornì le prove che le nubi sul cielo del fotogiornalismo erano già molto fitte nell’epoca in cui Cascio le vedeva nere.
La condizione del fotografo di informazione era definita già allora dai curatori come “di subalternità e sottocultura”, confinata in uno “status professionale sempre perdente”, il quadro dei media sconsolante, la fotografia utilizzata solo come “tappezzeria per dare aria alle colonne di piombo”.
Solo una nota finale di ottimismo della volontà temperava quel pessimismo della ragione: “È l’era dei due soldi di speranza: il fotoreportage uscirà dall’esclusione?”.
Quarant’anni dopo, scrissi recensendo la resurrezione di quella mostra, il fotogiornalismo non era ancora morto, e aveva nel frattempo combattuto buone battaglie.
La televisione non lo aveva ucciso, come temevano i fotografi di allora (e come quelli di oggi pensano del Web). La concentrazione delle testate non aveva eliminato del tutto la possibilità di far arrivare al pubblico un lavoro importante, etico, onesto.
Aveva torto allora Cascio? No, non aveva torto. Quel che vedeva era una malattia reale. La riduzione dell’immagine a illustrazione, ad esempio: “adesso basta che il giornale abbia una fotografia di un posto, scattata in una data circostanza, la mette lì e basta".
Poteva ben dirlo, lui che di immagini “messe lì e basta” non ne aveva fatte. Aveva lavorato da indipendente, vendendo i servizi alle agenzie internazionali, ma scegliendo lui dove andare e cosa raccontare.
Lo aveva fatto con un occhio e uno stile che non erano né quelli della un po’ distaccata, dettagliata, avalutativa fotografie di reportage americana, né l’indulgenza un po’ sentimentale e “buonista” dei fotografi umanisti francesi, ma una via nostra, italiana, che sposa l’etica di una antica tradizione civile alla cultura letteraria.
Aveva lavorato per i reportage dei rotocalchi, ma anche per libri meditati e profondi, come Quando io grido a te con testo di Ettore Masina (bisognerà pure scrivere una storia, un po’ messa in ombra dal mainstream impegnato prevalentemente a sinistra, dei fotografi che in Italia hanno avuto un rapporto con il pensiero e il mondo cristiano).
L'abbandono fu allora una scelta, personale, consapevole, sicuramente sofferta, quella di lasciare il mestiere che gli aveva riempito la vita giorno per giorno per tanti anni. Non una sconfitta.
Due fotografi di generazioni successive ebbero da lui una sorta di viatico ammonitore. Ferdinando Scianna, siciliano di origine come lui, ne raccolse l’amarezza. Francesco Zizola si sentì dire che le sue speranze” erano destinate a infrangersi sullo scoglio di editoria che si faceva sempre più mercato e propaganda”, e si impegnò a smentire la profezia (riuscendoci).
Dopo tutto, le profezie non servono solo se si avverano, ma anche se suscitano sforzi per combatterle. Il fotogiornalismo non è ancora morto, sta cambiano natura, forse, almeno in parte, sicuramente strumenti e canali, ma ancora non è morto
Lo si deve a chi lo ha amato, e magari lo ha abbandonato per stanchezza, ma con orgoglio “perché in fondo, le cose grosse della mia vita le ho viste”: una frase che può dire solo chi è stato, e nel cuore rimane, per sempre, fotoreporter.















.jpg)